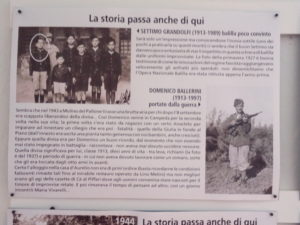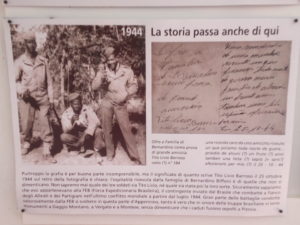Attraversata la diga di Isola Santa si imbocca il sentiero che porta al borgo fantasma di Col di Favilla. E’ un piccolo nucleo di case, parte del Comune di Stazzema, che erano nate, nel XVII secolo, come alpeggio. Nel corso del tempo il borgo si è sviluppato raggiungendo, alla fine del ‘800, una popolazione stabile. Pesantemente danneggiato durante la guerra di Liberazione è stato definitivamente abbandonato negli anni ’60.
L’escursione non è niente di eccezionale: molto tranquilla, direi per tutti. Un dislivello di poche centinaia di metri, il sentiero ben segnato, pendenze non esagerate… eppure c’è qualche cosa di diverso, di inquietante. Sarà il fatto di non incontrare altri mammiferi, se non un piccolo scoiattolo. Sarà forse la suggestione ispirata dalla salita verso un “borgo fantasma”, oppure sarà il fatto che Andrea Piazza non doveva guardare tutte le puntate di “Stranger Things” prima di partire😳. Sta di fatto che questo bosco ha qualche cosa di “stregato”.
Giro una curva e mi trovo di fronte un tronco in cui è facile individuare la sagoma di un volto umano, quasi come fosse un demone che controlla la salita. Giro attorno al tronco e lo scopro cavo, tanto che pare di poterlo abbattere con una mano. Ecco, era solo un “demone fragile”. E mi vien da pensare che, molto spesso, anche i nostri “demoni” sono solo paure fragili, basterebbe girarci intorno per scoprire che sono come tronchi vuoti. Ma quello che manca, molto spesso, è proprio il coraggio di affrontarli i nostri demoni. (questa era da manuale “Psicoterapia for Dummies”, voglio il copyright)
Intanto procedo e mi trovo di fronte una “farfalla” che mi sbarra la strada. La guardo attentanemente, non è una farfalla. Si alza si abbassa, vola, poi si ferma quindi riparte ma non è una farfalla bensì una foglia. L’ho pure filmata ma mica ho capito il trucco, forse una lunghissima ragnatela che la teneva in sospeso, ma io mica l’ho trovata la ragnatela. Faccio spallucce e passo oltre. Questo bosco resta inquietante.

Arrivo a Col di Favilla e inizio a fotografare gli antichi ruderi di quelle case diroccate. Ad un tratto un rumore, una voce… faccio un salto e mi viene la pelle d’oca. OK, sono solo due ragazzi, le prime persone che incontro oggi. Ma alla luce delle premesse lo spavento era comprensibile.
Continuo a fotografare quei ruderi. Si intravedono i resti di un camino, pavimenti e il cielo che fa da soffitto (quando si dice “Il cielo in una stanza”🤣). E mi viene da pensare ai piedi che, tra il XVII e il XX secolo, calpestarono quei pavimenti. Se le pietre di una casa hanno una memoria allora queste pietre trasmettono, in modo molto intenso, il ricordo di vite vissute in epoche lontane.
Più tardi proseguo fino alla Foce di Mosceta ed al rifugio Del Freo dove mangio una spettacolare zuppa di verdure. Qui nel bosco soffia una brezza strana, è un vento leggero ma continuo. Adesso, col senno di poi, mi sovviene quello che, due giorni dopo nel borgo di Frassignoni, il vecchio Argante chiamava “il respiro della montagna”. Strane coincidenze appenniniche, o forse gli echi di un unico esistere al quale apparteniamo tutti.
Proprio una bella escursione, alla portata di tutti. Magari però non per quelli dotati di un’immaginazione fervida come la mia.🤦♂️🤣🤣